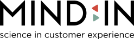Quando è uscito nelle sale – era il 2002 – il film Minority Report diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Cruise accese un focolaio di discussione: sarà possibile, in un futuro remoto, prevedere eventi criminali prima che questi avvengano? Di conseguenza, la giustizia potrà intervenire in maniera preventiva arrestando i “futuri” colpevoli? Sarà legale? Soprattutto, sarà etico?
Allora era fantascienza, e per quanto affascinante il tutto si fermò al livello della teoria, o della chiacchiera da bar. Ma se – come sta accadendo in questi giorni – a questo dibattito si toglie la “fanta”, e resta la “scienza” nuda e cruda, è il caso di prendere la cosa molto seriamente.
La disciplina che chiamiamo in causa è il neurodiritto, una branca della pratica giuridica che si basa sulle neuroscienze: un campo delicato e tutto da esplorare, che però sta già entrando in diverse aule di tribunale. Mettendo in discussione due capisaldi non solo del diritto, ma dell’intera civiltà umana: il libero arbitrio e il concetto di responsabilità.
La domanda di partenza è: il cervello sa – davvero – quello che stiamo facendo? O, meglio, quello che facciamo lo facciamo col cervello – inteso come razionalità – oppure con quella parte del nostro encefalo e quei percorsi neuronali che noi ancora conosciamo poco, e che le neuroscienze ci stanno insegnando a scoprire?
Altro che «Obiezione, vostro onore», come abbiamo sentito dire in migliaia di film.
Prima prova.
In un esperimentocondotto presso il Virginia Tech Carilion Research Institute, un gruppo di ricercatori è stato in grado di capire – per la prima volta basandosi solo sulle diverse attivazioni cerebrali – se un reato veniva commesso con o senza consapevolezza. Divisi in due gruppi e sottoposti a risonanza magnetica funzionale (fMRI), i partecipanti si trovavano di fronte alla decisione immaginaria di attraversare o non attraversare il confine di un Paese con una valigia. Mentre il primo gruppo era consapevole di trasportare merce di contrabbando, il secondo sapeva che la valigia avrebbe potuto contenere sostanze illecite ma non era messo a conoscenza del suo reale contenuto. Basandosi unicamente sui dati ottenuti con le scansioni cerebrali, i ricercatori sono riusciti a determinare con un alto grado di accuratezza quali soggetti erano consapevoli di infrangere la legge e chi, invece, agiva semplicemente in modo incauto. Anche se preliminari e ottenuti in via sperimentale, questi risultati potrebbero permettere in futuro di inferire, tramite le tecniche di brain imaging, a quale categoria legalmente rilevante appartenga un individuo, con importanti ripercussioni in sede giudiziaria. «Le persone», conferma uno dei neuroscienziati a capo della ricerca, Read Montague, «possono commettere esattamente lo stesso crimine in tutti i suoi elementi e circostanze e, a seconda dei loro stati mentali, la differenza potrebbe essere che uno andrebbe in prigione per quattordici anni e l’altro otterrebbe la libertà vigilata».
Seconda prova.
E se invece fosse il cervello a dire se un criminale, una volta uscito di prigione, commetterà un altro reato? Una ricerca condotta al The Mind Research Network di Albuquerque dimostrerebbe che con le brain imaging è possibile prevedere anche il rischio di recidiva di un ex detenuto. Nel loro studio, Kent Kiehl e collaboratori hanno scansionato, sempre tramite fMRI, il cervello di 96 prigionieri maschi prossimi al rilascio, mentre eseguivano al computer attività che richiedevano di prendere decisioni rapide e inibire le reazioni impulsive. Concluso il periodo di detenzione, i partecipanti sono stati seguiti per i successivi quattro anni, ovvero dal 2007 al 2010. Nello specifico i ricercatori si sono concentrati sulla corteccia cingolata anteriore (ACC), un’area deputata al controllo degli impulsi e che, in caso di danneggiamento, si associa a comportamenti disinibiti, aggressivi e difficoltà a rilevare i propri errori, riconoscerli e modificare il proprio comportamento. È emerso che gli ex detenuti con una bassa attività dell’ACC avevano il doppio delle probabilità di essere nuovamente arrestati rispetto a chi mostrava una maggiore funzionalità della stessa regione. «Questo studio non solo ci fornisce uno strumento per prevedere quali detenuti potrebbero recidivare e quali no, ma fornirà anche un percorso per indirizzare i criminali a terapie mirate più efficaci per ridurre il rischio di future attività illecite», ha spiegato Kiehl.
Inevitabilmente i risultati degli studi descritti sollevano domande di natura etica alle quali non sappiamo ancora rispondere. Ad esempio, può il cervello di una persona testimoniare contro di essa? Se in quanto sospettati di omicidio ci venissero richieste le impronte digitali o un campione del nostro dna, non potremmo opporci. Al contrario, però, potremmo avvalerci del diritto al silenzio e a non autoincriminarci. Secondo il sistema giuridico degli Stati Uniti, ad esempio, le prove autoincriminanti che non sono “fisiche” – come i nostri pensieri – sono protette dal Quinto Emendamento. Ma tra fisico e mentale dove vanno collocate le “prove” custodite all’interno del nostro cervello?